Il carcere è da secoli lo strumento principale attraverso cui gli Stati moderni rispondono al crimine. Ma è davvero efficace nel ridurre la recidiva? E cosa accade alla persona detenuta dopo la pena? La sociologia penale – branca della sociologia che studia le norme, le sanzioni e le istituzioni penali – offre una chiave di lettura critica e articolata del sistema punitivo, mettendo in luce i suoi limiti, le sue contraddizioni e le sue potenzialità trasformative.
La funzione della pena secondo la sociologia
Tradizionalmente, la pena è stata giustificata da tre principali funzioni: retributiva, deterrente e rieducativa. Tuttavia, numerosi sociologi hanno messo in discussione l’efficacia e la legittimità di questi modelli.
Il sociologo francese Émile Durkheim (1893), ad esempio, riteneva che la pena non servisse tanto a punire l’individuo colpevole quanto a rafforzare la coesione sociale, riaffermando i valori condivisi attraverso la condanna del crimine. Per Durkheim, la punizione è quindi un atto simbolico, più che uno strumento di prevenzione.
Diversamente, Michel Foucault, nel suo celebre saggio “Sorvegliare e punire” (1975), ha criticato l’istituzione carceraria come mezzo di controllo sociale e disciplinamento dei corpi. Secondo Foucault, il carcere non riforma, ma piuttosto riproduce marginalità e devianza, consolidando le disuguaglianze sociali.
Il carcere come istituzione totale
Il concetto di “istituzione totale” elaborato da Erving Goffman nel 1961 si applica perfettamente al carcere. In questi ambienti, l’individuo perde la propria autonomia e identità sociale, sostituite da ruoli e comportamenti imposti dall’organizzazione carceraria. Questo processo di mortificazione del sé ha gravi conseguenze sul reinserimento della persona una volta uscita dalla detenzione.
La socializzazione carceraria, infatti, può portare a quello che il criminologo Donald Clemmer ha definito “prisonization”: l’interiorizzazione delle norme e dei codici di comportamento tipici del mondo carcerario, che rende difficile il ritorno alla vita civile.
Reinserimento sociale: una sfida strutturale
Uno degli obiettivi dichiarati della pena, soprattutto nei sistemi europei, è la rieducazione e il reinserimento sociale. Tuttavia, studi empirici mostrano come le possibilità di reinserimento siano fortemente limitate da fattori strutturali: discriminazione, mancanza di supporto sociale, assenza di opportunità lavorative, e stigmatizzazione sociale.
Secondo uno studio del Consiglio d’Europa (2020), i tassi di recidiva si riducono significativamente in presenza di programmi di educazione, formazione professionale e sostegno psicologico durante e dopo la detenzione.
In Italia, esperienze virtuose come quella della Cooperativa Sociale Giotto nel carcere di Padova o i laboratori teatrali di Armando Punzo nel carcere di Volterra dimostrano come l’arte, il lavoro e la cultura possano diventare strumenti concreti di reinserimento.
Alternative al carcere: un nuovo paradigma
La sociologia penale contemporanea propone sempre più frequentemente l’adozione di misure alternative alla detenzione, come la giustizia riparativa, i lavori di pubblica utilità, la probation e la detenzione domiciliare.
La giustizia riparativa, in particolare, si concentra sul ripristino del legame tra autore del reato, vittima e comunità. Ricercatori come Howard Zehr e John Braithwaite hanno mostrato come questo approccio possa favorire un’autentica responsabilizzazione del reo e un processo di guarigione per la vittima.
La sociologia penale invita a ripensare la pena non solo come punizione, ma come opportunità di ricostruzione sociale. Il carcere, così com’è strutturato oggi, spesso fallisce nei suoi obiettivi dichiarati e rischia di essere una fabbrica di recidiva. Investire in politiche di inclusione, educazione e sostegno è una strada non solo più umana, ma anche più efficace per la sicurezza collettiva.
Come sottolineava il sociologo Norbert Elias, la civiltà di una società si misura anche dal modo in cui tratta i suoi “devianti”. E forse è proprio lì, al margine, che si gioca la qualità della nostra democrazia.
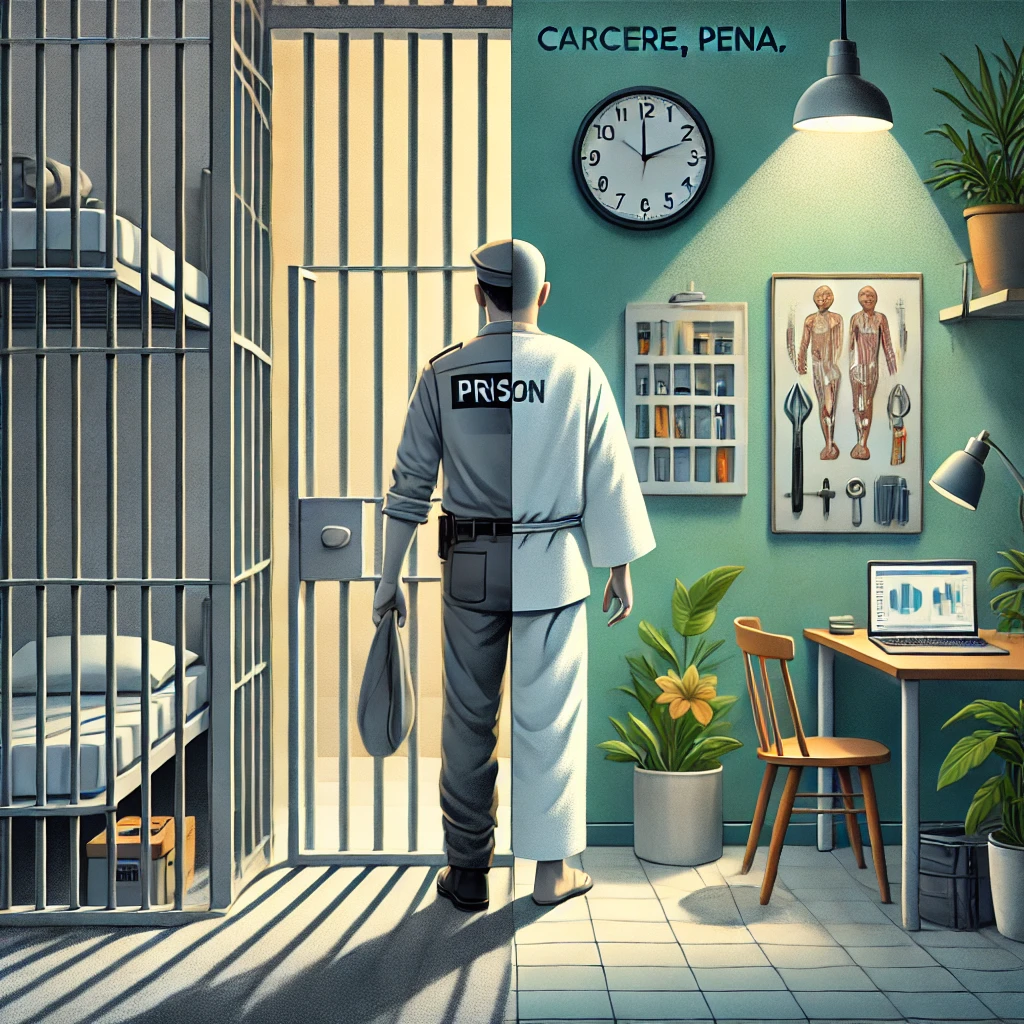
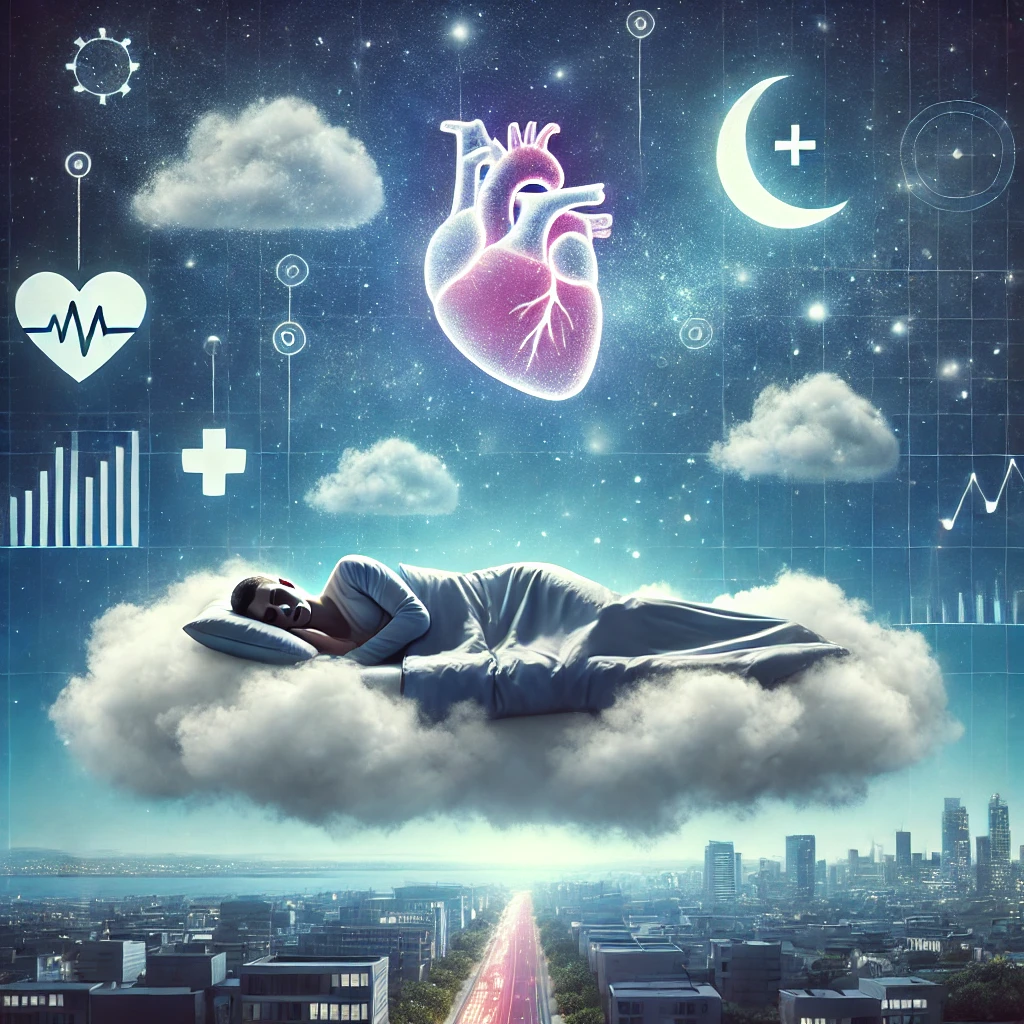


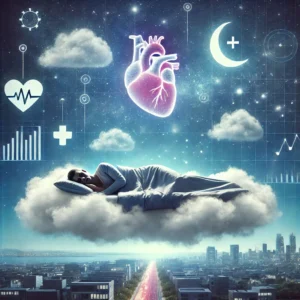



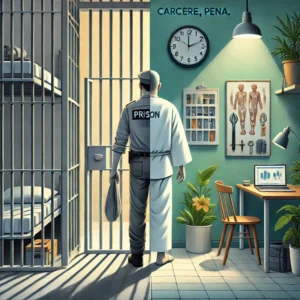



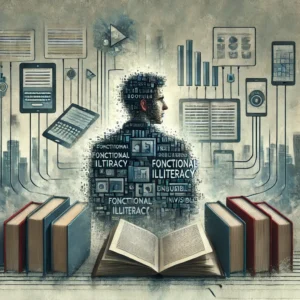
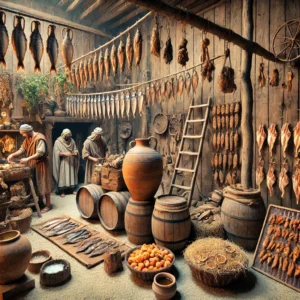
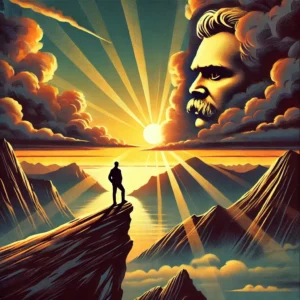
Commento all'articolo